
Il profeta inascoltato
C’è una forma di solitudine più dura di tutte:
quella di chi comprende prima degli altri
e non può più convincere nessuno.
Negli anni Trenta, mentre l’Italia si abitua alla voce unica del regime,
Gabriele D’Annunzio osserva l’Europa con uno sguardo che non è più lirico,
ma tragicamente lucido.
Non parla da capo politico.
Non parla da oppositore.
Parla da uomo che ha visto la guerra da vicino
e ne riconosce l’odore prima che esploda.
L’ombra che sale dal Nord
Dalla Germania arriva qualcosa che inquieta il poeta.
Non solo un nuovo potere,
ma un nuovo fanatismo.
D’Annunzio non si lascia sedurre da Adolf Hitler.
Non ne ammira la brutalità.

Non ne subisce il magnetismo.
Al contrario, lo percepisce come un pericolo profondo:
rozzo, violento,
privo di quella dimensione culturale
che, nel bene e nel male, aveva ancora segnato l’Italia.
Per lui, Hitler non è un alleato.
È una minaccia.
Lo dice in privato.
Lo scrive.
Lo lascia trapelare con frasi taglienti,
ironie amare,
avvertimenti che pochi vogliono raccogliere.
Capisce che quell’uomo non porterà ordine,
ma distruzione.
E capisce che l’alleanza con la Germania
trascinerà l’Italia in una guerra
che non può vincere.
Avvertire senza comandare
Ma D’Annunzio non ha più strumenti.
Non ha piazze.
Non ha giornali.
Non ha partiti.
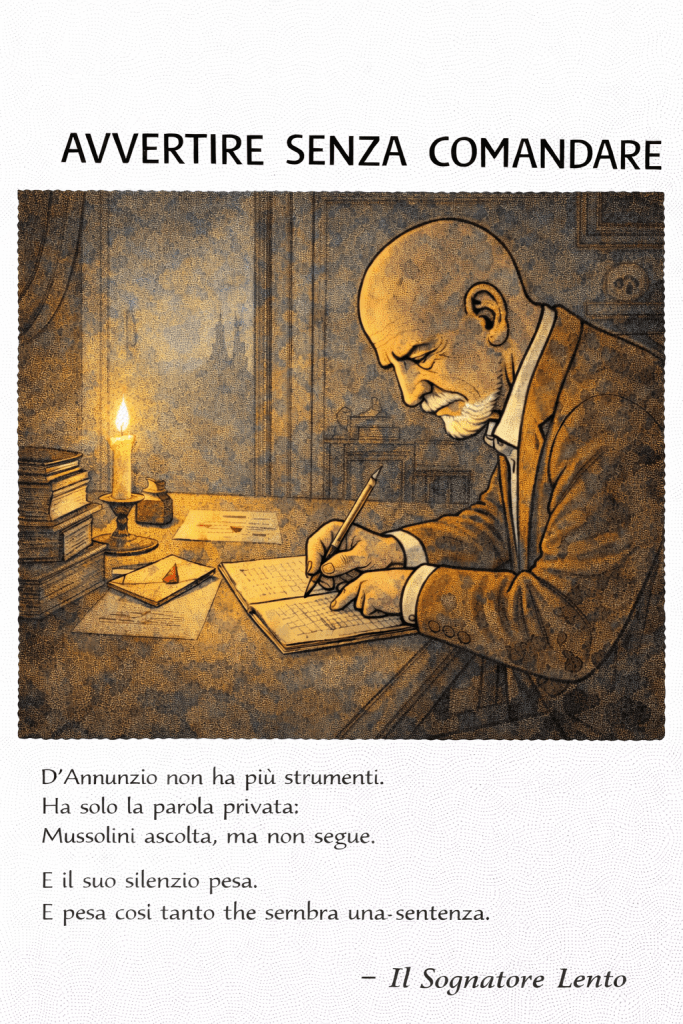
Ha solo la parola privata:
la lettera,
l’allusione colta,
la frase che pesa come una sentenza.
Mussolini ascolta con rispetto formale.
Ma non segue.
Il tempo della cautela è finito.
Il regime vuole potenza,
vuole grandezza,
vuole un posto tra gli imperi.
Le paure del poeta
appaiono a molti come debolezze senili.
Come malinconia.
Come residuo di un altro mondo.
E invece sono preveggenza.
La guerra vista da chi l’ha conosciuta
D’Annunzio non è un pacifista.

Non lo è mai stato.
Ma conosce la guerra vera:
quella che mutila,
che consuma,
che lascia dietro di sé
più silenzio che gloria.
Sa che l’Italia non è pronta.
Sa che il popolo è stanco.
Sa che l’eroismo,
senza mezzi e senza misura,
diventa macello.
Per questo parla.
E per questo viene ignorato.
La sua voce non serve più a mobilitare.
Serve a frenare.
E la storia, quando corre,
non ama i freni.
Il paradosso del profeta

C’è un paradosso crudele nella vecchiaia di D’Annunzio:
l’uomo accusato per anni di essere incendiario
diventa colui che invita alla prudenza.
Ma il mondo non gli riconosce questo cambiamento.
È prigioniero della propria leggenda.
Per molti resta il poeta della guerra.
Il cantore dell’azione.
Il simbolo dell’eccesso.
Non riescono a vederlo per ciò che è diventato:
un uomo che teme il futuro
più di quanto abbia mai temuto il nemico.
Un ascolto mancato
Quando l’Italia si avvicina sempre di più alla Germania,
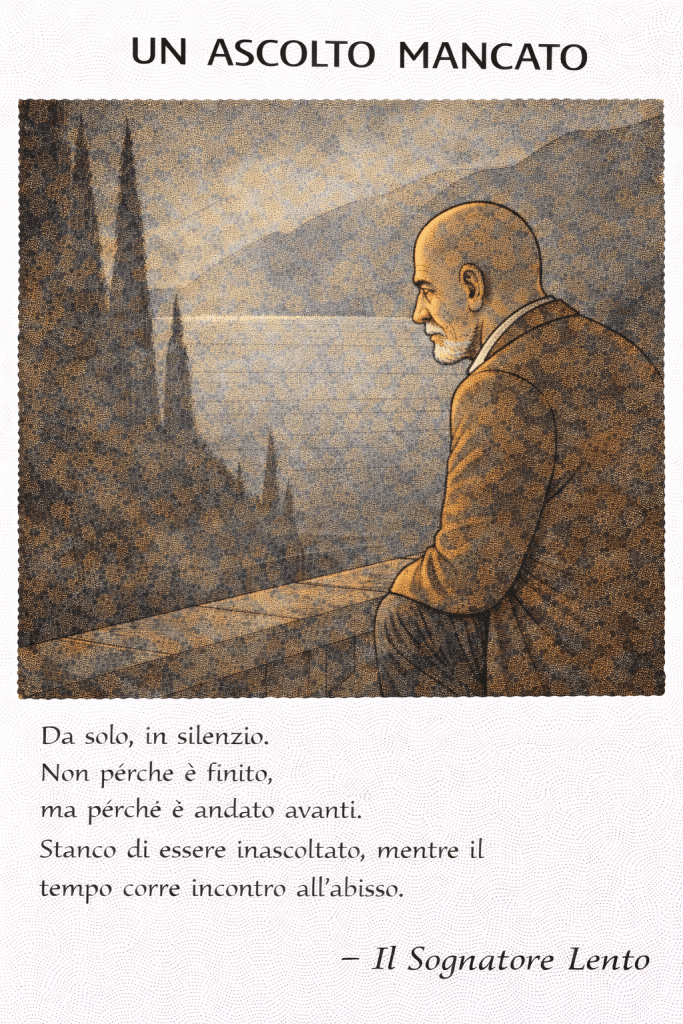
D’Annunzio comprende che il suo tempo di influenza è finito.
Non insiste.
Non si espone pubblicamente.
Non rompe.
Si ritira ancora di più
nel silenzio del Vittoriale.
Non perché rinunci a pensare,
ma perché capisce che le sue parole
non cambierebbero il corso degli eventi.
Il profeta non è colui che viene seguito.
È colui che ha ragione troppo presto.
Chiusura
Il Capitolo 25 si chiude così:
con un uomo che vede arrivare la tempesta
e non può fare altro che annotarne i segni.
La guerra che temeva verrà.
L’alleanza che avversava si compirà.
Il disastro che aveva intuito
diventerà realtà.
E allora, quando sarà troppo tardi,
qualcuno ricorderà
che un poeta, chiuso in una casa sul lago,
aveva provato ad avvertire.
Ma la storia non premia
chi ha ragione.
Premia chi arriva al potere
nel momento giusto.

Lascia un commento