
Sien
Sien non arrivò come un incontro.
Arrivò come arrivano le cose che non cercano consenso.
Vincent van Gogh la vide per strada, in uno di quei giorni bassi dell’Aia, quando il cielo sembra una coperta sporca stesa sopra i tetti e l’aria promette pioggia senza mai concederla davvero.
Il freddo non pungeva.
Pesava.
Le case avevano lo stesso colore del fango.
Le persone camminavano con il passo corto, come se non volessero disturbare il silenzio.
E lì, sul bordo del marciapiede, c’era lei.
Ferma.
Non in attesa di qualcuno.
In attesa di niente.
Incinta.
Le mani gonfie.
Le spalle cadute in avanti.
Accanto a lei una bambina troppo quieta per la sua età, con quello sguardo già adulto che a volte hanno i figli della povertà.
Non c’era scena.
Non c’era dramma.
Solo realtà.
Si chiamava Clasina Maria Hoornik.
Tutti la chiamavano Sien.
E bastava guardarla un secondo per capire che la vita non le aveva fatto sconti, che ogni anno le si era appoggiato addosso come un peso, scavandole il volto, piegandole le spalle e togliendole perfino l’abitudine di sperare.
La scelta che non sembra una scelta
Vincent non si avvicinò come un salvatore.
Non disse: posso aiutarti?
Non fece gesti solenni.
Semplicemente non riuscì ad andarsene.
Perché per lui guardare era già un coinvolgimento.
E quando guardava davvero qualcosa, non poteva più far finta che non esistesse.
La linea tra osservare e vivere, dentro di lui, si stava cancellando.
Così Sien entrò nella sua stanza.
Poi nella sua giornata.
Poi nel suo lavoro.
Senza dichiarazioni.
Come entrano le necessità.
Non la prese con sé per carità.
Non si sentiva buono.
Non si sentiva generoso.
La prese perché separare arte e vita stava diventando una bugia.
E lui non sopportava più le bugie, soprattutto quelle che si raccontava da solo.
Una casa che non protegge
La stanza era piccola.
Un letto.
Un tavolo.
La stufa che tossiva più che scaldare.
Odore di carbone, di carta, di panni umidi.
La povertà non aveva bisogno di essere dipinta:
era già lì, appesa ai muri.
Sien si sedeva quando poteva.
Si appoggiava.
Respirava piano, come chi ha imparato a non occupare spazio.
A volte posava per lui.
A volte dormiva.
Spesso stava semplicemente lì.
E quella presenza bastava.
Il bambino che portava in grembo si muoveva sotto il vestito consunto.
Non come un simbolo.
Come un peso.
Un peso vero.
Vincent lo vedeva.
E non voleva trasformarlo in allegoria.
Il corpo che non permette distanza
Disegnarla non era tecnicamente difficile.
Era difficile moralmente.
Perché non lasciava scampo.
Quel corpo non permetteva eleganza.
Non permetteva grazia.
Costringeva a dire la verità.
Le spalle curve.
Le caviglie gonfie.
La stanchezza incisa nella pelle.
Niente idealizzazione.
Niente “bellezza”.
Solo presenza.
Vincent si avvicinava molto.
Troppo, per alcuni.
Ma era l’unico modo che conosceva.
Ogni segno doveva pesare quanto la carne.
Ogni linea doveva portarsi dietro la fatica.
Se addolciva, mentiva.
Se abbelliva, tradiva.
E lui non voleva tradire.
Quando la vita entra nel foglio
Con Sien il lavoro cambiò natura.
Non era più studio.
Era convivenza.
Il modello non tornava a casa.
Era casa.
Mangiavano insieme.
Dividevano il pane.
Dividevano il silenzio.
C’erano giorni in cui non si disegnava affatto.
La bambina piangeva.
Sien tossiva.
Il carbone finiva.
La miseria non era più un “tema sociale”.
Era la lista della spesa.
Era contare le monete.
Era scegliere tra carta e cibo.
Vincent scriveva a Theo senza eroismi.
Non diceva: sto facendo qualcosa di grande.
Diceva:
è difficile
è costoso
sono stanco.
Parole semplici.
Parole vere.
Lo scandalo silenzioso
All’Aia la gente cominciò a guardarlo di lato.
Non apertamente contro.
Peggio.
Con quella cortesia fredda che è già un rifiuto.
Una prostituta.
Incinta.
In casa di un pittore senza soldi.
Non servivano spiegazioni.
La sentenza era già scritta negli sguardi.
La famiglia si fece più distante.
Le lettere più dure.
Anton Mauve si allontanò.
Le porte si chiusero una alla volta.
Come in inverno.
Senza rumore.
Vincent lo sapeva.
Sapeva che stava scegliendo la parte sbagliata della città.
La parte che nessuno vuole raccontare.
Eppure restò.
Non per coraggio.
Per coerenza.
Tornare indietro avrebbe significato far finta che lei fosse solo un soggetto.
E non lo era.
L’errore necessario
Non fu una storia dolce.
Non fu un rifugio.
Ci furono litigi.
Stanchezza.
Giorni in cui si sopportavano a fatica.
Sien non era una musa.
Era una donna reale, con bisogni, malanni, paure.
E Vincent non era un compagno stabile.
Era inquieto.
Assorbito dal lavoro.
Spesso altrove con la testa.
Due fragilità che cercavano di reggersi a vicenda.
A volte ci riuscivano.
A volte no.
Ma proprio lì, nell’imperfezione, successe qualcosa.
Per la prima volta Vincent non parlava della vita.
Stava dentro la vita.
Con tutto il peso.
Con tutto il disordine.
Quando l’arte smette di essere innocente
Da quel momento il foglio non fu più neutro.
Ogni figura diventò una responsabilità.
Ogni volto una scelta morale.
Non poteva più disegnare “tipi umani”.
Erano persone.
Con nomi.
Con fame.
Con freddo.
L’arte smise di essere esercizio.
Diventò presa di posizione.
Non cercava più la bellezza.
Cercava la verità.
E la verità, quasi sempre, era scomoda.
Questo lo isolò.
Ma lo rese più lucido.
Più essenziale.
Più suo.
Restare nel punto più scomodo
Con Sien, Vincent scelse il punto dove nessuno vuole stare.
Dove arte, povertà e responsabilità si toccano.
Dove non puoi più separare ciò che fai da ciò che sei.
Non trovò pace.
Trovò attrito.
Ma per lui l’attrito era necessario.
Come il carbone per accendere il fuoco.
Senza attrito non c’è calore.
Senza resistenza non c’è segno.
Senza quella convivenza scomoda, probabilmente, non sarebbe diventato l’artista che conosciamo.
Perché imparò una cosa definitiva:
non puoi raccontare la vita
restando al riparo.
Devi sporcarti le mani.
Devi perdere qualcosa.
Devi restare dove fa male.
Con Sien non trovò salvezza.
Trovò peso.
E quel peso entrò nei suoi disegni.
Rimase nelle linee.
Nelle ombre.
Nella durezza del tratto.
Da quel momento in poi, niente fu più “studio”.
Tutto fu esperienza.
E quando la vita entrò davvero nel foglio,
il foglio smise di mentire.
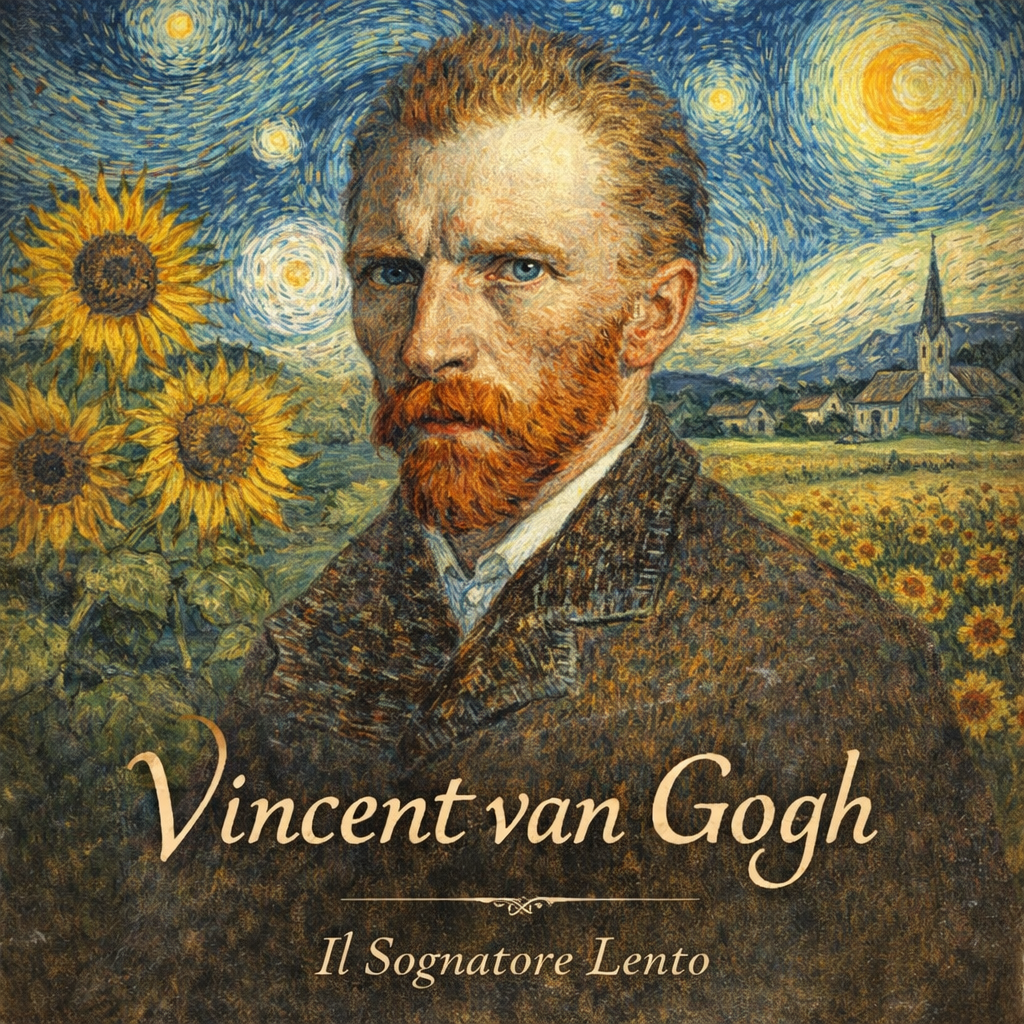
Lascia un commento