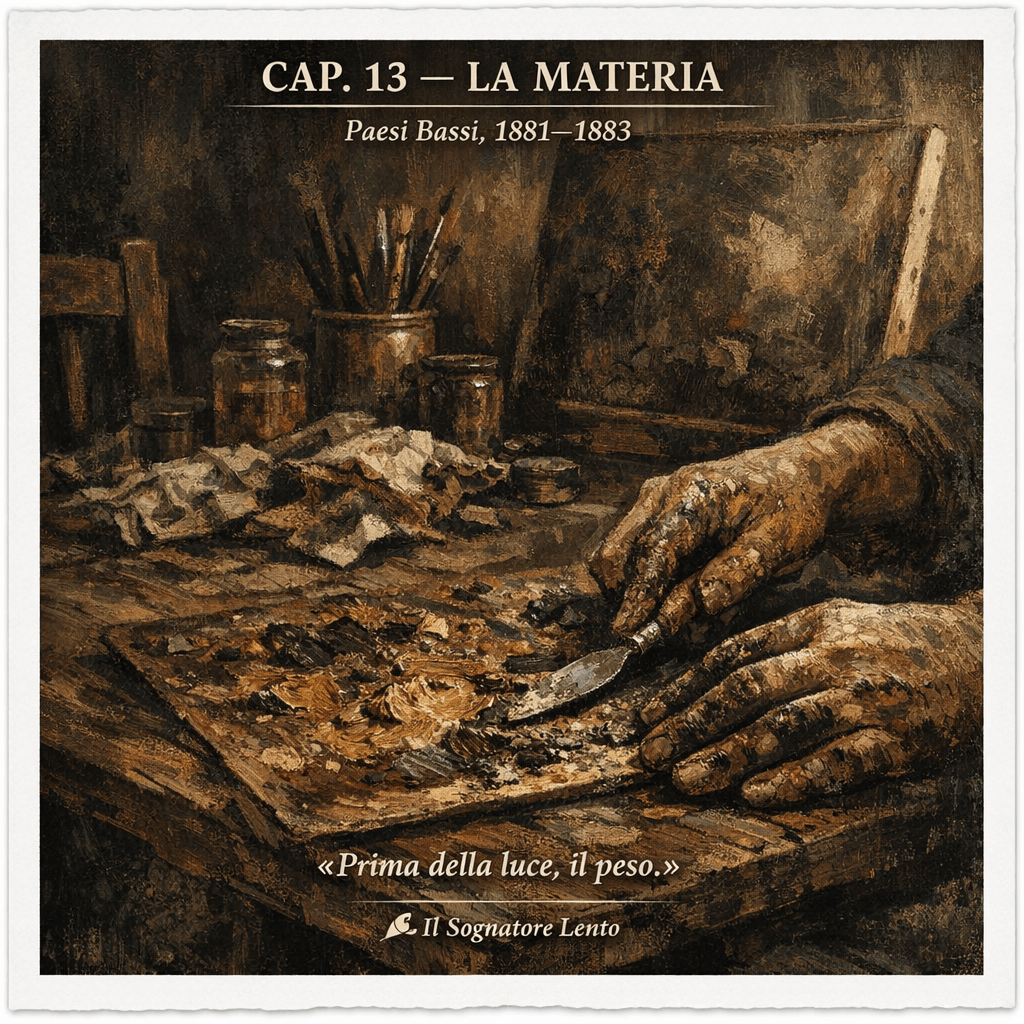
Capitolo13 – La materia
Paesi Bassi, 1881–1883
I primi tentativi a olio non arrivarono come una conquista.
Non furono un salto.
Non furono un’illuminazione.
Arrivarono come una fatica.
Una di quelle fatiche che non fanno rumore,
ma ti restano addosso come polvere.
Il colore non obbediva.
Era denso, lento, testardo.
Non seguiva la mano.
Non scivolava come il disegno.
Con la matita poteva correggere.
Con il carboncino poteva sporcare, sfumare, tornare indietro.
Con l’olio no.
Ogni gesto restava.
E restare, per lui, era la cosa più difficile.
Nella primavera del 1881 Vincent van Gogh non tornò a casa.
La casa dell’infanzia era rimasta a Zundert, insieme ai ricordi e a un tempo che non esisteva più.
I genitori si erano spostati.
Il padre, pastore protestante, veniva mandato dove serviva.
Le parrocchie cambiavano.
Le stanze cambiavano.
Le finestre cambiavano.
Così Vincent non fece ritorno.
Raggiunse i genitori nella nuova parrocchia di Etten-Leur.
Arrivò come uno che chiede ospitalità.
Aveva quasi trent’anni, ma dentro si sentiva più giovane e più stanco di prima.
Aveva provato troppe strade.
Troppe partenze finite male.
Mercante d’arte.
Insegnante.
Predicatore.
Ogni volta qualcosa si era rotto.
Ora non cercava più una vocazione.
Cercava solo di restare in piedi.
Etten non prometteva nulla.
Strade basse, fango dopo ogni pioggia.
Campi piatti, lunghi, senza orizzonte.
Case scure.
Finestre piccole.
La luce non cadeva mai davvero: sembrava trattenuta, come se il cielo avesse paura di esporsi.
Nessun colore vivo.
Nessun movimento.
Solo terra.
Terra e silenzio.
All’inizio lo irritava.
Poi capì che quella povertà visiva era una forma di sincerità.
Non c’era niente da abbellire.
Solo da guardare.
Cominciò con le cose più vicine.
Una sedia.
La sedia della cucina, graffiata, sbilenca.
La guardò come si guarda una persona.
Poi il tavolo.
Le tazze sbeccate.
Gli zoccoli lasciati accanto alla porta.
Oggetti che nessuno avrebbe dipinto.
Ed era proprio per questo che li voleva.
Non cercava soggetti importanti.
Cercava presenza.
Cose che pesassero.
Poi arrivarono le mani.
Le mani dei contadini.
Le vedeva la domenica, all’uscita dalla chiesa.
Nodose, screpolate, dure come corteccia.
Mani che non avevano mai conosciuto riposo.
Non c’era grazia in quelle dita.
C’era resistenza.
E lui voleva quella.
Le prime tele furono scure.
Brune.
Terrose.
Quasi fangose.
Il colore non veniva steso: veniva spinto.
Come terra contro terra.
Premuto.
Schiaffato contro la tela.
Come se dovesse rimanere incollato.
Guardandole non si respirava.
Non c’era aria.
Sembravano quadri scavati più che dipinti.
Eppure non gli dispiacevano.
Sentiva che doveva passare da lì.
Come attraversare il fango prima di raggiungere l’asciutto.
Non cercava la luce.
La luce gli sembrava una promessa troppo facile.
Cercava il peso.
Voleva che le cose stessero in piedi da sole.
Passava ore davanti alla tela senza quasi muoversi.
Guardava l’olio cambiare lentamente.
Asciugare.
Opacizzarsi.
Diventare crosta.
Capì che l’olio non era solo colore.
Era tempo.
Un tempo che non poteva essere forzato.
Non potevi dire: adesso.
Dovevi aspettare.
Come aspettano i campi.
Quella lentezza lo irritava e lo calmava insieme.
Era costretto a restare.
A guardare davvero.
A non scappare.
La pittura diventò una forma di resistenza.
Resistere all’errore.
Resistere alla goffaggine.
Resistere alla voglia di buttare via tutto.
Molte sere si sentiva incapace.
Le figure rigide.
I volti spenti.
La luce sempre troppo bassa.
Ma il giorno dopo tornava.
Sempre.
Perché almeno lì non stava fingendo.
Stava lavorando.
E il lavoro, anche quando falliva, lo teneva intero.
Dopo mesi capì che non bastava soffrire.
Bisognava imparare.

Così lasciò il Brabante e si spostò a L’Aia.
La città lo spaventò.
Troppa gente.
Troppi rumori.
Troppi pittori veri.
Atelier che odoravano di olio e trementina, finestre alte, tele grandi appoggiate ai muri come porte spalancate.
Per la prima volta qualcuno guardava il suo lavoro senza indulgenza.
«Troppo pesante.»
«Troppo scuro.»
«Non respira.»
All’inizio gli faceva male.
Ogni frase era come una crepa.
Poi capì.
Quella durezza non era disprezzo.
Era rispetto.
Lo trattavano come uno che poteva migliorare.
Non come un dilettante da incoraggiare.
Era la prima forma di fiducia vera.
L’acquerello lo costrinse alla leggerezza.
Non poteva coprire.
Non poteva correggere.
Non poteva nascondere.
Ogni errore restava lì, nudo.
Era crudele.
Ma giusto.
Imparò a guardare prima di toccare.
A fermarsi.
A togliere invece di aggiungere.
A lasciare spazio.
Quando tornò all’olio, qualcosa era cambiato.
Non combatteva più la materia.
La ascoltava.
Strato su strato.
Lento.
Come costruire un muro con pazienza, pietra dopo pietra.
Un giorno, lavorando su un interno povero, accadde una cosa piccola.
Non un miracolo.
Non una rivelazione.
Solo lavoro.
Silenzio.
Pennello sporco.
Il tavolo davanti a lui era sempre lo stesso.
Legno scuro, scheggiato, unto di anni.
Lo aveva già dipinto altre volte.
Male.
Troppo piatto.
Troppo compatto.
Troppo morto.
Quella mattina non stava cercando niente.
Stava solo insistendo.
Passava il colore piano, quasi controvoglia.
Lo tirava.
Lo spingeva.
Lo toglieva con lo straccio.
Finché, senza accorgersene, lasciò una parte più sottile.
Meno carica.
Come se la mano avesse esitato.
E lì successe.
Il bordo del tavolo non pesava più.
Non era più legno.
Respirava.
Non una luce forte.
Non un effetto.
Solo aria.
Come se tra il buio e il colore si fosse aperto un passaggio.
Restò fermo.
Il pennello sospeso a mezz’aria.
Guardava quel niente come si guarda una finestra che qualcuno ha socchiuso dall’altra parte della stanza.
Non aveva aggiunto.
Aveva tolto.
Forse il colore non andava dominato.
Forse andava lasciato accadere.
Lasciato vivere.
Rimase lì a lungo, in silenzio.
Per la prima volta la materia non era un peso.
Era tempo.
Respiro.
Ma anche la città, a poco a poco, divenne stretta.
Le strade troppo rumorose.
Le voci troppo vicine.
Gli atelier pieni di discorsi su vendite, clienti, successo.

Si parlava di carriera.
Lui continuava a pensare alle mani dei poveri.
Alle sedie rotte.
Ai corpi stanchi che nessuno voleva guardare.
Sentiva di star imparando a dipingere.
Ma non ancora a vivere.
La pittura diventava più solida.
Più consapevole.
Lui no.
Dentro restava una mancanza.
Un vuoto che la tecnica non poteva riempire.
Gli mancava un peso vero.
Qualcosa che non fosse studio.
Non fosse esercizio.
Non fosse distanza.
Qualcosa che entrasse nella stanza senza bussare
e gli impedisse per sempre di restare spettatore.
Non lo sapeva ancora.
Ma la vita stava già camminando verso di lui.
Senza teoria.
Senza bellezza.
Con passi stanchi.
Avrebbe avuto un nome semplice.
Sien.

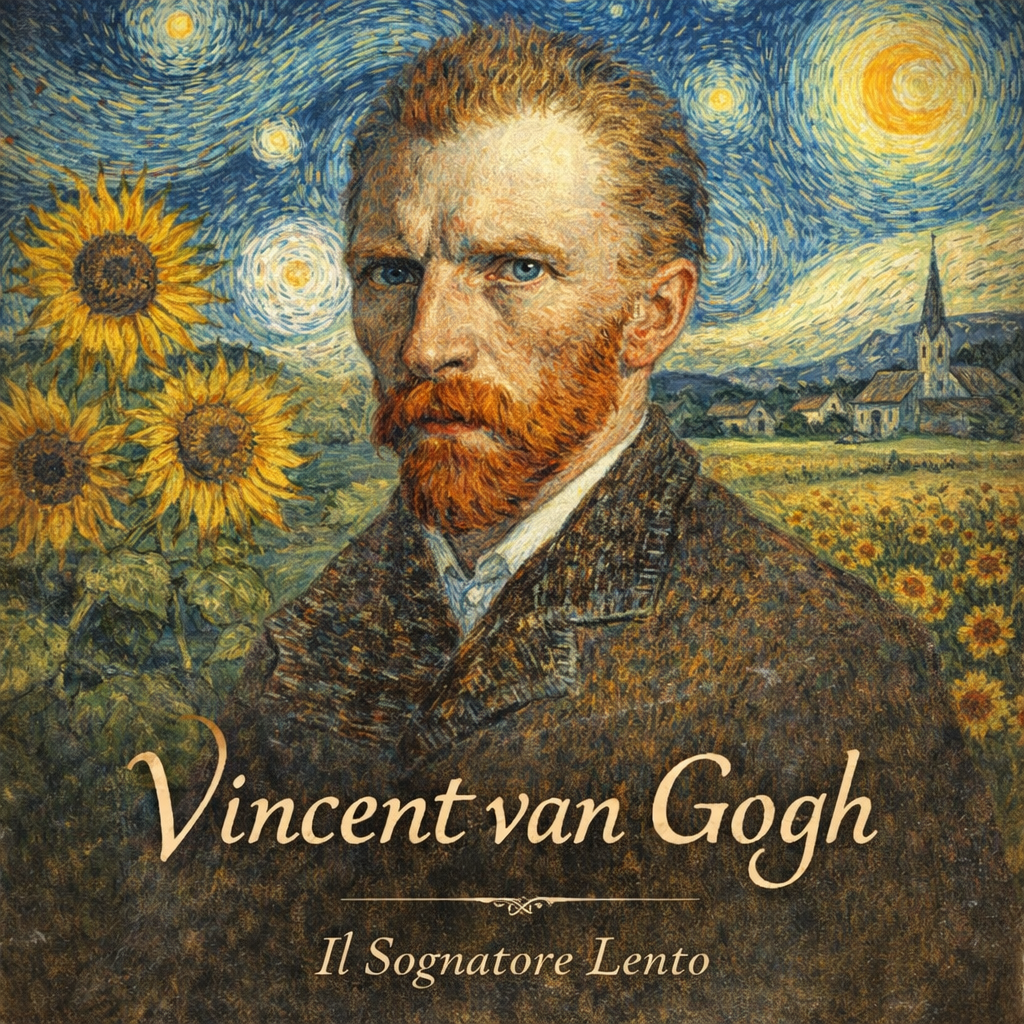
Lascia un commento